L’insostenibile leggerezza dello Zen
Verso la fine del XIX secolo lo scambio culturale che i Paesi occidentali hanno avuto con l’Oriente si è fatto particolarmente ricco, generando mode e tormentoni nell’intellighenzia e spesso influenzando il pensiero filosofico. Lo Zen (禅) assume una posizione di riguardo in tal senso, rafforzando la sua presenza in particolare durante il movimento beat americano negli anni ’60. La tradizione Zen nasce nella religione induista per sfociare durante i secoli nel buddhismo con diverse forme e scuole, differenziandosi in particolare tra il ceppo cinese e quello giapponese.
Non sono mai stato particolarmente attratto dal fascino esotico di queste dottrine, né soprattutto dai seguaci occidentali che spesso ne traviano i significati o vi speculano sopra.
Come spesso accade, le traduzioni culturali di continenti lontani rischiano lo scimmiottamento da parte degli occidentali, che non hanno gli strumenti per comprenderne il vero senso.
È risaputo che l’obiettivo e il contenuto delle dottrine Zen è comunque la realizzazione del Satori(悟), che diversamente dal nirvana (rimasto particolarmente impresso, ad esempio, nel pensiero di Schopenhauer) si prospetta come una partecipazione attiva e consapevole al mondo piuttosto che una rinuncia completa al mondo attraverso il distacco da esso.
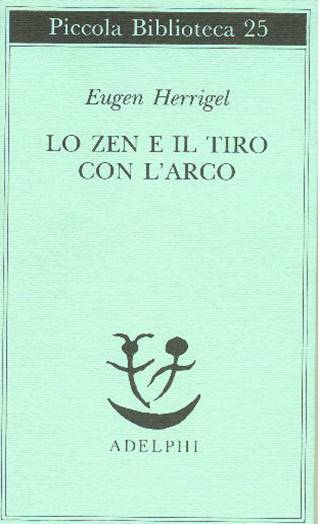 « Satori, in termini psicologici, è un oltre i confini dell’Io. Da un punto di vista logico è scorgere la sintesi dell’affermazione e della negazione, in termini metafisici è afferrare intuitivamente che l’essere è il divenire e il divenire è l’essere. » (Daisetz T. Suzuki, dall’introduzione del libro Lo zen e il tiro con l’arco)
« Satori, in termini psicologici, è un oltre i confini dell’Io. Da un punto di vista logico è scorgere la sintesi dell’affermazione e della negazione, in termini metafisici è afferrare intuitivamente che l’essere è il divenire e il divenire è l’essere. » (Daisetz T. Suzuki, dall’introduzione del libro Lo zen e il tiro con l’arco)
Il termine deriva dal giapponese “rendersi conto” e sottintende un risveglio spirituale, dove non si coglie più la differenza tra il soggetto che prende consapevolezza e l’oggetto di osservazione. Come descrive Herrigel (in un saggio su sé stesso come ennesimo occidentale folgorato dalla cultura orientale) nel volume appena citato il soggetto “Si” mira, “Si” colpisce e “Si” estranea mescolandosi con l’obiettivo dell’arciere nel suo tiro. Il pensiero che si distacca dalle operazioni e permette un’efficacia potente nell’attività che si conduce è davvero tipica nel pensiero orientale. La ripetitività (mantra) e la riduzione dell’emotività permettono una crescita determinante nell’arte insegnata da un maestro (di vita più che di tecnica).
Seppur con un po’ di riluttanza sono costretto a scorgere delle metafore intriganti nella cultura orientale. Il distacco, la solitudine con sé stessi, la riflessione interiore, la costruzione di un percorso di crescita sono tutte parole chiave dell’accezione auto-formativa dell’apprendimento.
Ciò che mi discosta è la stridente dissonanza con la pratica quotidiana e il tumulto delle ansie occidentali legate al materiale, al capitale, all’individuale. Temo che anche il più caparbio shōgun non saprebbe resistere ai ritmi di vita forsennati e psicopatici della vita occidentale postmoderna.
 Per questo mi sento di definire questo rapporto con l’approccio zen come non sostenibile sebbene leggero. Come il classico di Kundera, il concetto paradossale è espresso tra il contrasto dell’evanescenza della vita, fatta di scelte spesso sfuggenti e superficiali e la chiara necessità di trovare nella vita stessa delle risposte sul senso dell’esistenza. Ciò che si verifica una volta sola è come se non fosse mai accaduto – Ein Mal ist kein Mal – una volta è nessuna volta e, come direbbe Sartre, se mi è dato scegliere, il fatto di non poter discernere si traduce in una non scelta – e perseguire un apprendimento zen nella vita occidentale non può che rimanere una breve, seppur piacevole, parentesi all’interno di un periodo complesso e articolato di parafrasi dell’esistenza.
Per questo mi sento di definire questo rapporto con l’approccio zen come non sostenibile sebbene leggero. Come il classico di Kundera, il concetto paradossale è espresso tra il contrasto dell’evanescenza della vita, fatta di scelte spesso sfuggenti e superficiali e la chiara necessità di trovare nella vita stessa delle risposte sul senso dell’esistenza. Ciò che si verifica una volta sola è come se non fosse mai accaduto – Ein Mal ist kein Mal – una volta è nessuna volta e, come direbbe Sartre, se mi è dato scegliere, il fatto di non poter discernere si traduce in una non scelta – e perseguire un apprendimento zen nella vita occidentale non può che rimanere una breve, seppur piacevole, parentesi all’interno di un periodo complesso e articolato di parafrasi dell’esistenza.
Inoltre, il presupposto dell’apprendere rimane comunque l’insufficienza di una capacità oltre che la tensione ad acquisirla. Si apprende tanto più quanto siamo motivati estrinsecamente ed intrinsecamente allo stesso tempo. Possiamo pertanto essere molto motivati ad imparare l’antica arte del tiro con l’arco se non siamo motivati a fare il “vuoto” dentro di noi per raccogliere il mistero dello zen, direbbe Herrigel, ma tantomeno non acquisiremo come effettuare il tiro correttamente se non abbiamo un obiettivo a cui tendere. L’obiettivo esterno deve tramutarsi in interno e non il contrario. Altrimenti la logica diventa assolutamente occidentale: esternare le tensioni interiori, possibilmente piegando gli eventi e le persone a proprio favore è una logica tremendamente “coloniale” dell’esistenza.
 Tali presupposti ricordano il paradosso del barbiere di Russell, raccontato magistralmente in questo passo da Quine:
Tali presupposti ricordano il paradosso del barbiere di Russell, raccontato magistralmente in questo passo da Quine:
Per alcune decadi invero, gli studi sui fondamenti della matematica sono stati turbati e notevolmente stimolati dalla considerazione di due paradossi, uno proposto da Bertrand Russell nel 1901, e l’altro da Kurt Gödel nel 1931. Come primo passo su questo terreno accidentato consideriamo un altro paradosso: quello del barbiere del villaggio. […] In un certo villaggio c’è un uomo, così dice il paradosso, che è un barbiere; questo barbiere sbarba tutti, e soltanto, quegli uomini che non si sanno sbarbare da soli. Quesito: il barbiere sbarba se stesso? Ogni uomo in questo villaggio è sbarbato dal barbiere se, e solo se, non si sa sbarbare da solo. In particolare, quindi, il barbiere sbarba se stesso se, e solo se, non sa sbarbarsi. Siamo in difficoltà se affermiamo che il barbiere si sbarba, e altrettanto se affermiamo il contrario. (W. V. O. Quine, I paradossi, in A. Pasquinelli (a cura), Il neopositivismo, Torino, UTET, 1969)
In entrambi i casi abbiamo vi sono due contraddizioni che non permettono lo scioglimento del paradosso. L’insostenibile leggerezza dello zen sarà sempre in contrasto con la sete di sapere di mediterranea memoria: “né dolcezza di figlio, né la pieta / del vecchio padre, né ‘l debito amore /lo qual dovea Penelopé far lieta,/ vincer potero dentro a me l’ardore /ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto, / e de li vizi umani e del valore” (Dante, Inferno, Canto XXVI, v. 94-99).